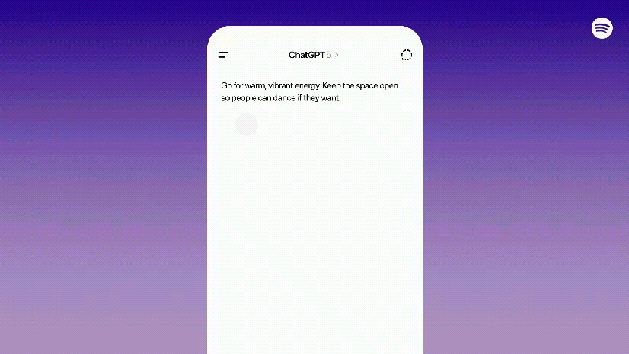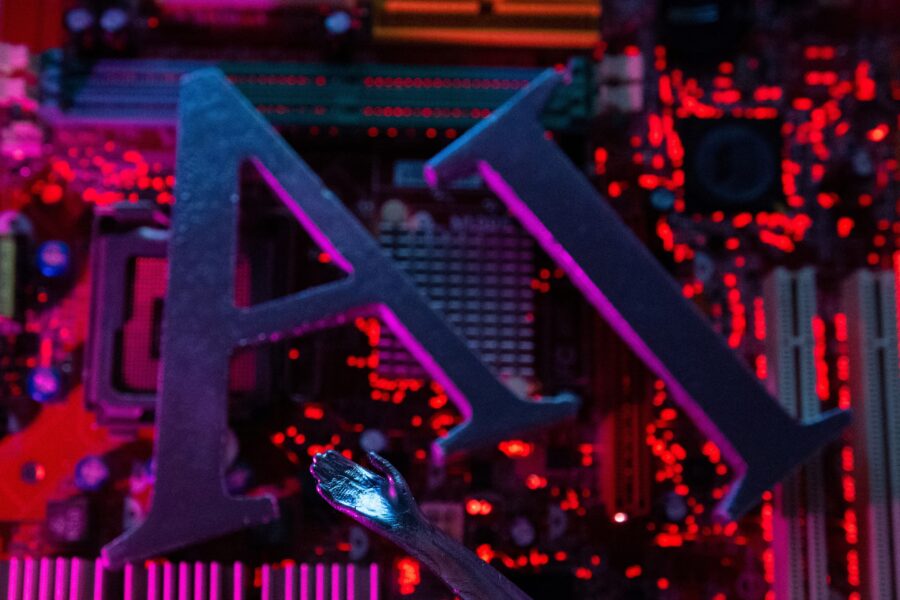Nel mondo dei robot umanoidi, la narrazione dominante oscilla tra colossi hollywoodiani come Tesla Optimus e Boston Dynamics Atlas, macchine che sembrano più stuntman da film che strumenti pratici. Ma c’è un outsider che silenziosamente sta riscrivendo le regole del gioco: il Unitree G1. Non impressiona per altezza o glamour tecnologico, ma per la sua accessibilità economica e per il modo geniale in cui impara dai movimenti umani reali. Il prezzo di circa 16.000 dollari lo rende appetibile per università, club di robotica e startup, un robot “di massa” che sfida la logica dei grandi headline-grabbing bot.