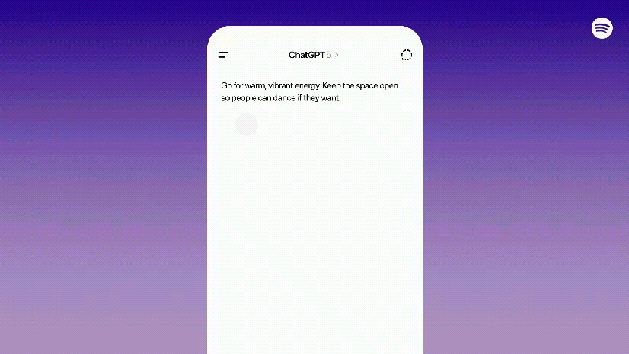Una delle tendenze più evidenti del mercato infrastrutturale digitale è che la domanda spinta da intelligenza artificiale, elaborazione in cloud e generative AI sta crescendo con velocità che mette sotto pressione la capacità infrastrutturale disponibile. Secondo il report Global Data Center Trends 2025 di CBRE, “demand continues to outpace new supply” nei principali hub mondiali, e il tasso di vacanza medio dei data center è sceso a circa 6,6 %, con strette particolarmente acute nei cluster di potenza e nelle zone core.
Ma cosa significa “domanda che sorpassa capacità” in concreto? Significa che i provider iperscalatori (Microsoft, Amazon, Google, etc.) e i grandi clienti enterprise stanno correndo a prenotare spazi e potenza molto prima che le strutture siano costruite; molti progetti vengono “preleased”cioè venduti in anticipo — e le tempistiche di consegna si estendono oltre il 2027, spesso per vincoli sull’energia, permessi, interconnessioni e forniture.