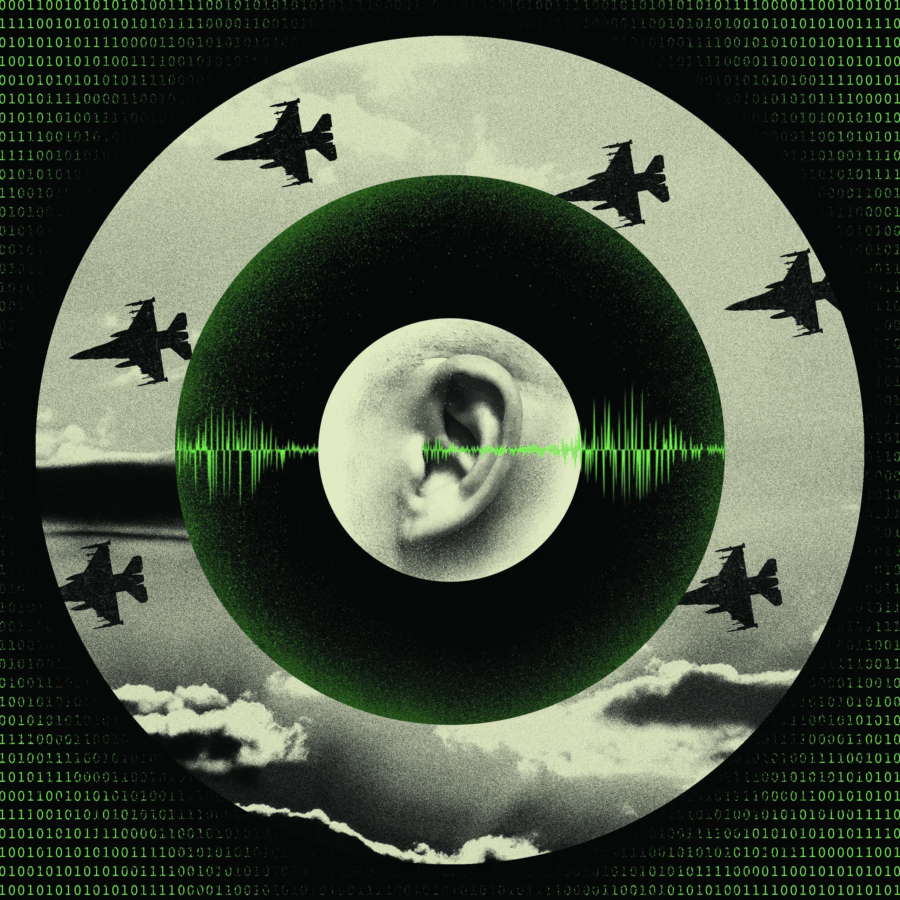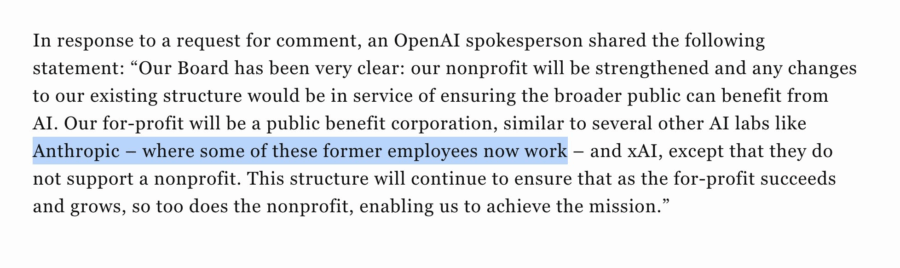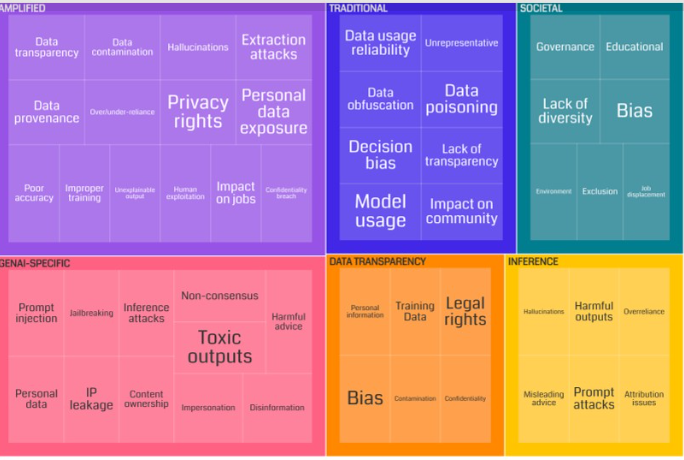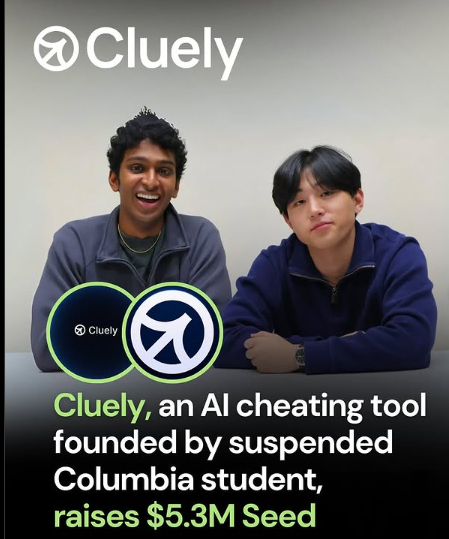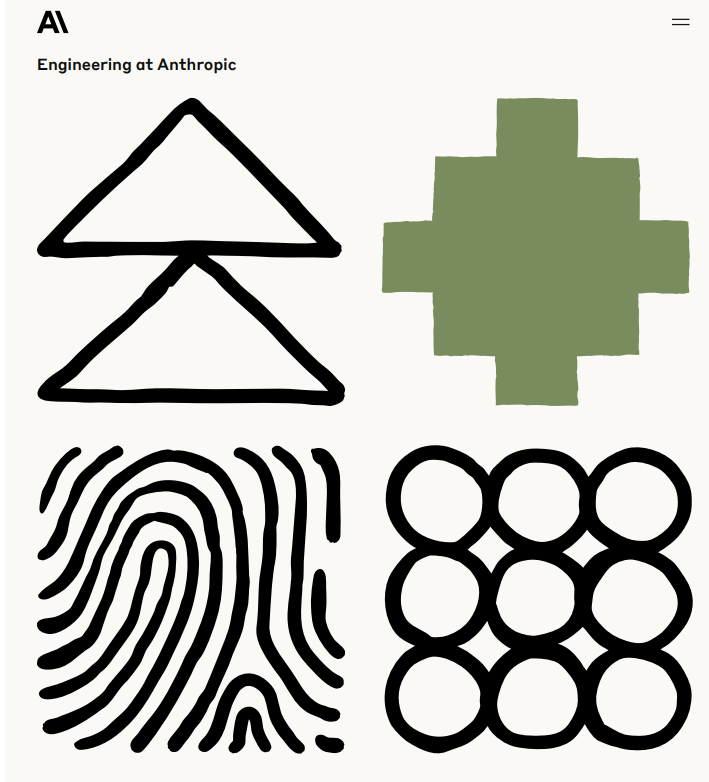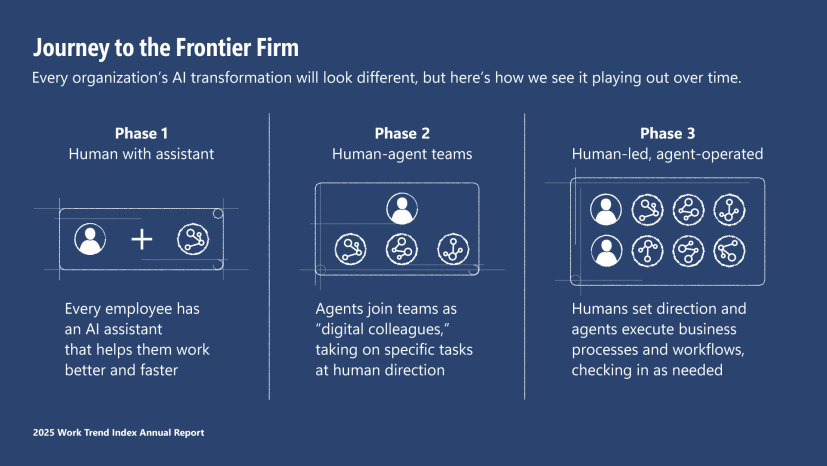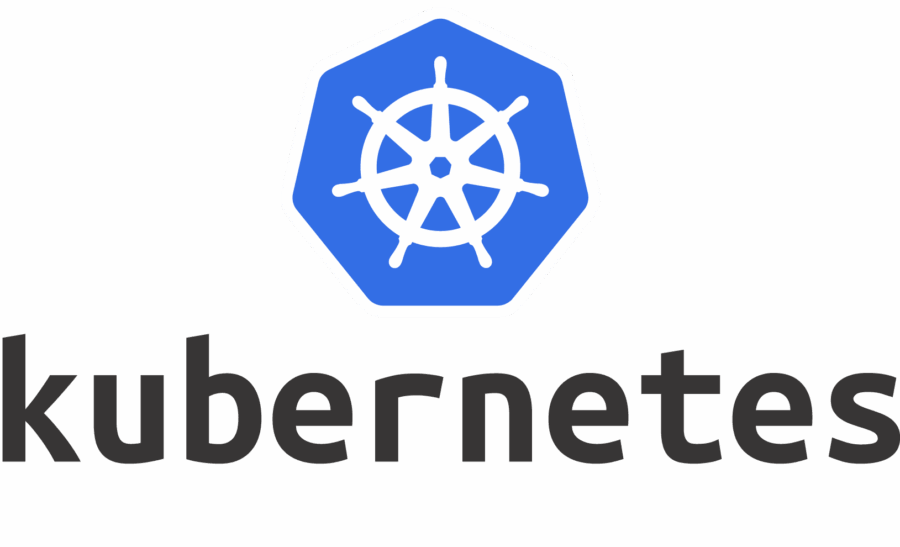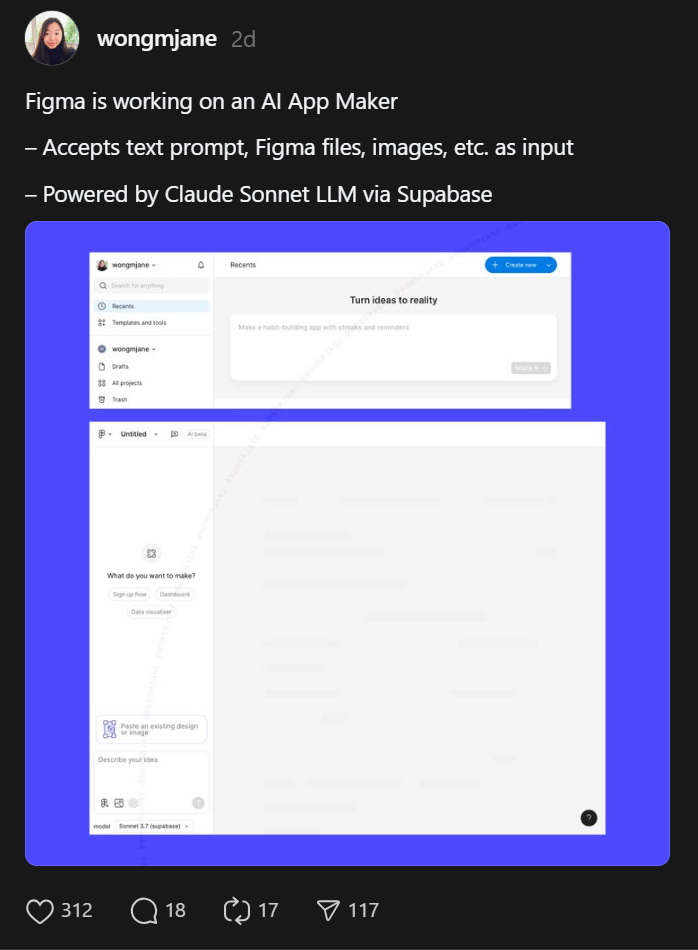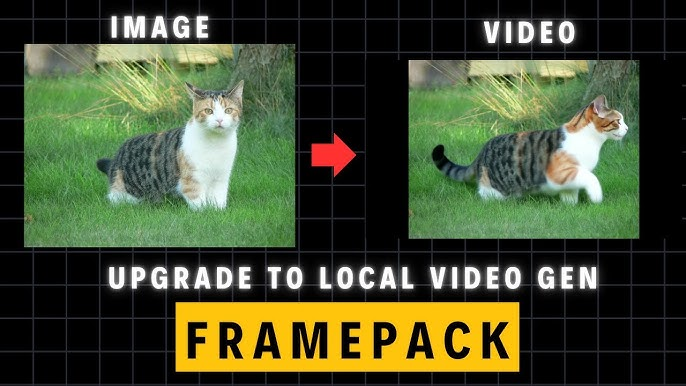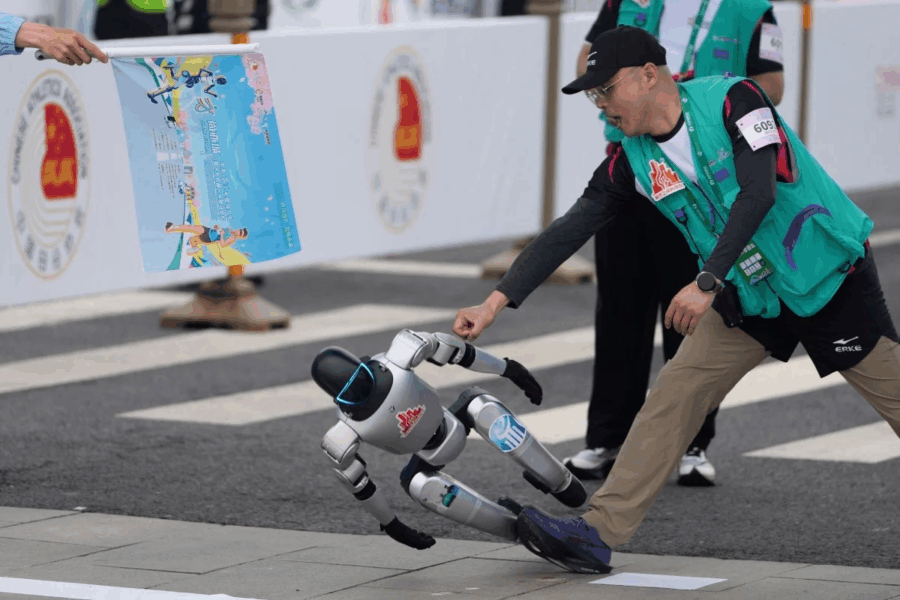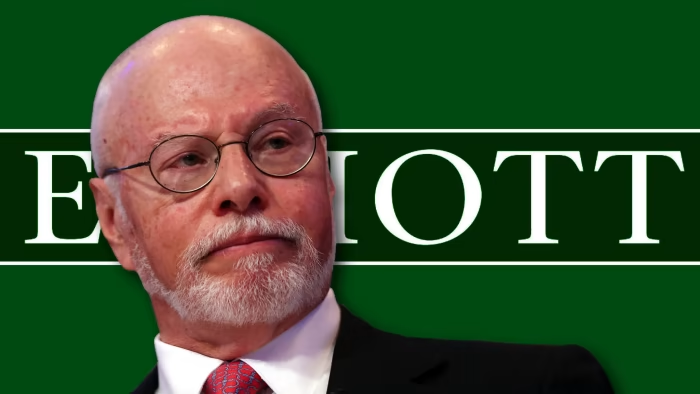Ci sono giorni che scorrono lenti, e poi ci sono giorni che meritano un brindisi. O almeno un applauso silenzioso, magari davanti allo schermo, mentre sfogli il sito della Commissione Europea e ti imbatti in una piccola perla celebrativa: un booklet. Non un PDF qualunque, ma un compendio che racconta 40 anni di investimento europeo in ricerca e innovazione. Un’epopea di traguardi, fallimenti utili, idee folli diventate tecnologie fondamentali, e sogni lucidamente pianificati.
Perché sì, ogni passo in avanti va celebrato come fosse il primo. Non per ingenuità, ma per metodo. Perché nel nostro mondo iperveloce, dimentichiamo troppo facilmente che la realtà si costruisce un grant alla volta, una call vinta, una partnership internazionale, una sperimentazione riuscita. E spesso la grandezza dei risultati si rivela solo in retrospettiva. Ed è proprio quello che fa questo booklet commemorativo: fermarsi, voltarsi e guardare con un misto di orgoglio e stupore tutto ciò che è stato costruito da quando, nel 1984, l’Unione Europea ha deciso che finanziare la scienza e l’innovazione non era un atto caritatevole, ma un investimento politico, economico e strategico.
Quaranta storie simboliche, selezionate non per la loro spettacolarità ma per la loro capacità di rappresentare un ecosistema. Leggendole si percepisce l’intento narrativo: mostrare l’impatto concreto del funding europeo, non solo in termini tecnologici ma anche sociali e culturali. Dalle biotecnologie alla cybersicurezza, dal cibo sostenibile all’esplorazione spaziale, passando per la digitalizzazione delle PMI, la mobilità elettrica e la cooperazione internazionale con paesi extra-UE. C’è tutto. O almeno abbastanza per restituire l’ampiezza del campo da gioco.
È un documento volutamente divulgativo, quasi sentimentale nella sua impaginazione sobria e nelle sue fotografie istituzionali. Ma sotto la superficie, per chi sa leggere tra le righe, c’è una narrazione strategica: l’Europa non è mai stata così tanto una potenza di ricerca come lo è ora. E lo è perché ha avuto la lucidità, negli anni, di investire in infrastrutture scientifiche, reti accademiche, open science, modelli di governance del rischio. Ha sbagliato, corretto, riformulato. E ha continuato a finanziare. Horizon 2020, Horizon Europe, ERC, EIT: acronimi diventati, per chi vive questo mondo, pane quotidiano.
Celebrarne i 40 anni non è solo un atto di memoria istituzionale, ma un posizionamento politico. In un momento in cui le sfide globali si moltiplicano e le pressioni sulle democrazie liberali si fanno sempre più sistemiche, l’Europa sceglie di ribadire una cosa: il sapere scientifico è un bene comune, e va sostenuto con risorse pubbliche, visione di lungo periodo e pazienza strategica.
E c’è un ulteriore livello da non ignorare. Questa raccolta di storie è anche un invito implicito a continuare. A non cedere al cinismo tecnocratico, a non dare per scontato che l’innovazione accada da sola. Perché non succede. Richiede commitment, regole chiare, persone visionarie e strutture solide. Richiede che ogni piccola vittoria venga riconosciuta. Che ogni prototipo, ogni paper, ogni pilot validato, venga trattato con la dignità del seme che un giorno sarà albero.
Insomma, festeggiare ogni successo come se fosse il primo non è retorica motivazionale, è metodo scientifico applicato alla politica. E in un mondo che spesso dimentica il valore dell’iter, questa piccola celebrazione editoriale ci ricorda che sì, anche l’Unione Europea ogni tanto sa dire grazie. E lo fa con un booklet. Perché la forma è sostanza. Anche nella burocrazia.
Ti lascio il link per leggerlo e magari lasciarti ispirare: 4
E già che ci sei, celebralo davvero. Come fosse la prima volta.