Il 21 aprile 2025, alle 07:35 CEST, Jorge Mario Bergoglio ha cessato di vivere nella Domus Sanctae Marthae, vittima di un ictus seguito da un collasso cardiocircolatorio irreversibile; alle complicazioni si aggiungevano pregressi episodi di polmonite bilaterale, ipertensione e diabete di tipo II, come attestato dal certificato medico ufficiale rilasciato dal dottor Andrea Arcangeli.
Poche ore dopo, il cardinale camerlengo Kevin Farrell ha dato lettura dell’annuncio al mondo intero, sigillando l’inizio di una veglia pubblica senza precedenti.
Già il 23 aprile la Basilica di San Pietro ha aperto le porte alla camera ardente: una semplice cassa di legno, modello “rinuncia ai fasti”, ha accolto lunghissime file di fedeli, non meno di 20.000 persone tra pellegrini, curiosi e cronisti, disposti in coda sotto il solleone primaverile per rendere omaggio all’ultimo interprete di un papato sempre in bilico tra spirito di servizio e tattiche mediatiche.
L’eco politica non si è fatta attendere: mentre il pontefice giaceva in stato, Donald Trump autorizzava bandiere a mezz’asta negli uffici federali statunitensi e pregustava la passerella romana del 26 aprile.

A Roma, un manipolo di “MAGA Catholics” dalla penna fumante di Steve Bannon fino ai microfoni di Jesse Romero sbandierava il ritorno a un cattolicesimo rigorosamente tradizionalista e schiacciato su un nazionalismo identitario, auspicando un successore capace di invertire la rotta progressista di Francesco.
Ma l’insidia più sottile di questa corrente “bianca” è emersa nei corridoi del potere vaticano, dove il vicepresidente JD Vance ha provato a scolpire un ordo amoris patriottico, dando priorità a famiglia e nazione anziché all’universale carità cristiana mossa che ha scatenato la replica indiretta del pontefice in una lettera ai vescovi USA, ribadendo il comandamento dell’amore come imperativo categorico e non come frazionabile geograficamente.

Nel frattempo, alla Casa Bianca si studiava un piano di comunicazione d’alto profilo: un Executive Order intitolato “Eradicating Anti-Christian Bias” prometteva di deporre la retorica dell’“attacco ai valori cristiani” sotto la forma di task force governative, e Trump stesso twittava ergersi “più religiosi che mai” era lo slogan di un mattino di Pasqua su Truth Social.
La mossa, abilissima nella sua superficialità, mirava a consolidare il consenso di un elettorato che vede nella fede una barricata emotiva contro “l’élite globalista”, ma non poteva cancellare la spaccatura teologico-politica che correva demarcata tra i cardinali di età e formazione diversa.
Ed è qui che entra in scena un conclave Kantiano, laddove la segretezza degli scrutini diventa un laboratorio di deontologia pratica: i porporati, chiusi nella Cappella Sistina, sono chiamati ad agire secondo massime che potrebbero aspirare a divenire leggi universali, trattando ogni fratello “cardinale come fine e non come mezzo” un esercizio di volontà che pare uscito da una pagina del “Groundwork” piuttosto che da un manuale agiografico.

A differenza dei conclavi passati, stavolta l’influenza nordamericana non si è giocata solo nei corridoi diplomatici, ma si è riversata apertamente sul dibattito interno, alimentata da un blocco coeso di cardinali statunitensi schierati lungo una precisa linea teologica e culturale. A guidare informalmente questa corrente ci sono figure come il cardinale Timothy Dolan di New York e l’astro nascente Robert Barron, teologo mediatico e fondatore del Word on Fire Institute, fautore di una “teologia del logos occidentale“, che sintetizza aristotelismo tomista e civiltà giudeo-cristiana in chiave apologetica anti-secolare.

Non si tratta solo di dottrina: la posta è identitaria. L’obiettivo, nemmeno troppo velato, è eleggere un pontefice in grado di arginare quella che viene percepita come una deriva globalista e “soft” del cattolicesimo sinodale di Francesco.
I cardinali americani, sostenuti da think tank come il Napa Institute e reti cattoliche come EWTN, spingono per un ritorno a una “ortodossia muscolare” che riabiliti la legge naturale, riaffermi il primato morale dell’Occidente e, sotto sotto, benedica l’ideologia del “Christian Nationalism” che serpeggia nei discorsi trumpiani. In parallelo, si muove una strategia di soft power: briefing riservati con i cardinali africani e asiatici, promesse di sostegno logistico e accademico, fondazioni che offrono borse di studio ai seminaristi stranieri “conformi” alla nuova ortodossia.
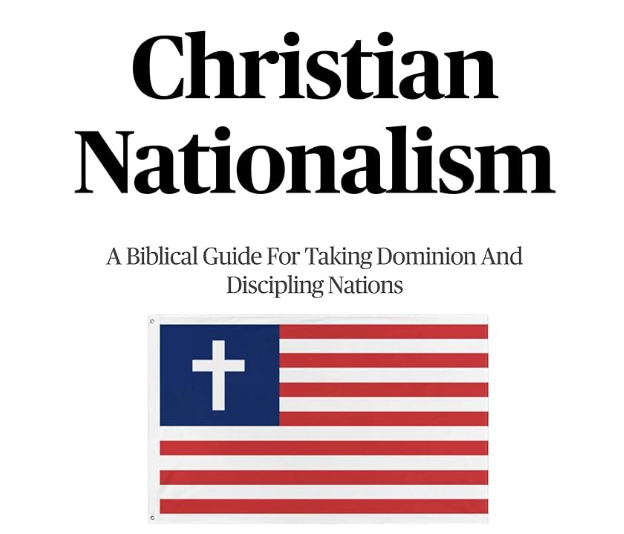
È l’ombra lunga di una teologia post-Benedetto, che intende rivestire di razionalismo scolastico l’identitarismo americano, e che considera l’enciclica Fratelli Tutti come un indebolimento della visione sacrale dell’ordine sociale. In questo scenario, il conclave non è più un esercizio di discernimento spirituale, ma una mappa geopolitica in miniatura, dove la partita tra modernità liquida e restaurazione metafisica si gioca sull’asse tra Roma e Washington. E forse, tra un caffè nel cortile del Belvedere (non quello del Bar dei Daini) e un’agenda condivisa su Telegram, qualche voto è già stato promesso.
L’autonomia morale viene così messa alla prova: il libero arbitrio dei cardinali deve resistere alle pressioni delle lobby geografiche, alle retoriche nazionalistiche del “cattolicesimo bianco” e alle sirene conservatrici di retroguardie ecclesiali tentate dal “ritorno all’antico”.
Eppure, questo avanguardismo kantiano coabita con un residuo teologico che non ha mai digerito l’etica della pura ragione: già Karol Wojtyła, in polemica col filosofo di Königsberg, criticava la disinteressatezza kantiana come negazione dell’unità tra Bene e Sommo Bene; la morale di dovere era ridotta a un freddo calcolo, incapace di cogliere la pietas del giudizio divino e l’istinto escatologico del perdono.
Il contrasto tra la “certezza di fede” che la Chiesa ritiene dono del Magistero e l’“imperativo categorico” kantiano spingerà i cardinali a misurarsi con la loro vocazione drammaturgica: garantire Gerarchia e Tradizione, sì, ma senza rinnegare lo slancio innovativo di un pontificato che ha fatto del dialogo con il mondo contemporaneo la sua cifra.
In coda a questi drammi filosofico-teologici, l’“algoretica” della Chiesa ovvero il tentativo di disciplinare eticamente il disegno algoritmico e l’intelligenza artificiale attende il proprio protagonista.
Il Vaticano, con il documento “Antica et nova”, ha già alzato l’allerta sul “shadow of evil” insito nelle macchine che generano deepfake e polarizzazione politica, e invita a un controllo serrato affinché l’IA resti strumento e non signore della dignità umana.
Ma chi siederà al soglio petrino deciderà se proseguire sulla linea di una “morale digitale” ispirata alla fraternitas universalis o abbandonarla in nome di un tradizionalismo difensivo, incapace di leggere i rischi e le opportunità offerte dalla rivoluzione tecnologica.
Il conclave si profila dunque come un bivio non solo geografico-politico, ma etico-tecnologico: l’esito stabilirà quali coordinate seguirà la Chiesa nella società algoritmica che verrà. La posta in gioco non è soltanto un nome su un trono, ma il bando o l’abbraccio di un’“algoretica” capace di armonizzare la tensione tra legge morale, fede religiosa e intelligenza artificiale.
