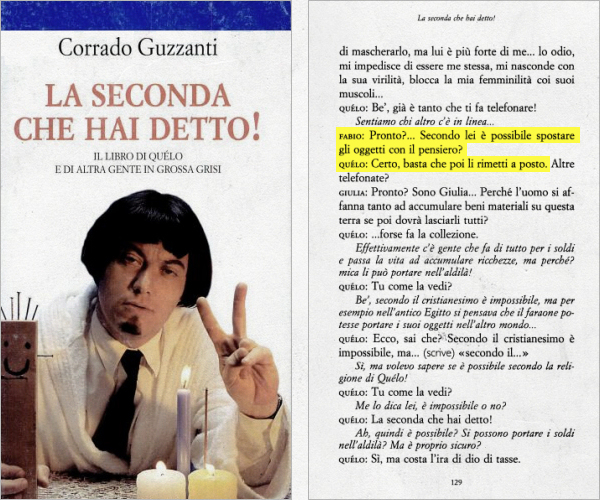Un caffè al Bar dei Daini.
La geopolitica è tornata con gli stivali chiodati a calpestare i campi minati della finanza globale. Pechino chiude i rubinetti agli investimenti nei fondi di private equity americani, e l’Europa comincia a strofinarsi gli occhi, cercando una via d’uscita più elegante di quella canadese, che ha già la valigia pronta.
Non è solo una ritirata: è un cambio di paradigma, una mutazione strutturale del flusso di capitali che ha drogato Wall Street per due decenni. A fare la bella vita a debito, denaro facile, sono capaci tutti, specialmente noi occidentali, ma i Cinesi sono abituati ad aspettare il momento invece.
Dalle notizie emerse, il China Investment Corporation (CIC), colosso da oltre mille miliardi, ha iniziato a sfilarsi dalle operazioni americane, bloccando nuovi investimenti e chiedendo di non partecipare nemmeno a operazioni con veicoli terzi che abbiano aziende statunitensi nel mirino.
Tradotto: “non vogliamo nemmeno sentirne parlare, anche se ci arrivate da Londra, Lussemburgo o Singapore”. Il contesto è l’ennesimo stallo a fuoco lento della guerra commerciale Usa-Cina, quella partita ufficialmente con Trump, ma che Biden ha solo elegantemente rifoderato in abiti multilaterali. I nuovi dazi americani sulle esportazioni cinesi sfiorano il 145%, e la risposta di Pechino è un 125% altrettanto velenoso. Non siamo più nel campo dell’economia, siamo in piena dottrina geopolitica applicata alla finanza.E questo ha un costo, un costo vero.
Il private equity americano, quello dei fondi chiusi, delle operazioni a leva, dei LBO su scale industriali, ha vissuto per anni sull’adrenalina delle masse monetarie asiatiche. Il denaro sovrano cinese non era solo liquido, era strategico, era stabile. Sapevi che se chiudevi un fondo con Blackstone o Carlyle, la fetta cinese arrivava puntuale. Ora quel banchetto è finito, e a spegnere la luce non è stato il mercato, ma Xi Jinping in persona.
Ma non finisce qui. Perché il vero brivido arriva dal contagio: anche alcuni investitori europei e canadesi stanno “rivalutando” (la parola più usata e più falsa della finanza) la loro esposizione agli Stati Uniti.
Per ora nessuno parla di una fuga di massa, ma i gestori iniziano a chiedere clausole di uscita, di rinegoziazione, di “wait and see”. La fiducia è un asset.
Quando cala, non si compra su Amazon.Il problema è che il private equity non è come i bond. È un gioco lento, illiquido, opaco, pieno di vincoli e lock-up. Se i capitali escono adesso, si aprono voragini future. Perché chi ha firmato commitment decennali senza i soldi della Cina (o del Canada, o dell’Europa), domani rischia di ritrovarsi con fondi sottoscritti al 40%.E allora?
Allora si apre uno scenario nuovo, uno di quelli che non si leggono nei report di McKinsey. I fondi Usa saranno costretti a rivolgersi a nuovi capitali, magari dai Paesi del Golfo, o più probabilmente ad alzare i rendimenti promessi in un mercato già in tensione. Gli LP (Limited Partner) locali chiederanno sconti, privilegi, forse persino governance.
Il risultato sarà un private equity più caro, più politicizzato, meno liquido.Dietro questa storia non c’è solo un disimpegno. C’è una guerra fredda che ha deciso di passare all’incasso, di colpire non più solo i prodotti finiti, ma l’ossatura finanziaria delle economie.
L’America ha voluto il decoupling, ora se lo ritrova anche nei fondi chiusi. E l’Europa, come sempre, si guarda allo specchio e cerca di capire se anche questa volta riuscirà a uscire dalla porta di servizio senza prendersi la colpa.
Nel frattempo, Pechino si costruisce la sua finanza alternativa, magari meno sexy, ma più controllabile. E Washington scopre che quando togli il denaro facile, anche l’impero dell’alternative asset management traballa.
Game over? No, solo reset. Ma stavolta senza la possibilità di salvare la partita. Mi ricorda tanto…