L’elezione di Jorge Mario Bergoglio al pontificato il 13 marzo 2013 ha rappresentato l’epilogo di un conclave intenso, carico di aspettative e sorprese. Secondo i resoconti degli scrutini, il cardinale argentino si affermò come figura di mediazione tra le opposte correnti: da un lato i sostenitori del riformista Angelo Scola, dall’altro i tradizionalisti vicini alla Curia. Al quarto scrutinio, Bergoglio raccolse 67 voti, sfiorando la soglia dei 77 richiesti, per poi raggiungere 85 preferenze al quinto scrutinio, superando il quorum dei due terzi. Questa elezione rifletteva l’esigenza di una guida in grado di combinare fermezza dottrinale e apertura verso le sfide del mondo contemporaneo, un tratto distintivo del suo intero pontificato.
La scomparsa di Papa Francesco Bergoglio segna la fine di un pontificato che ha ridefinito il rapporto tra fede ed etica. Primo Pontefice gesuita e proveniente dalle periferie del mondo, Bergoglio ha incarnato una figura di rottura, unendo umiltà francescana a una visione audace sull’innovazione.
Dalla storica elezione, segnata da un conclave diviso e da una fumata bianca ricca di speranze, Papa Francesco ha affrontato più volte il tema dell’Intelligenza Artificiale. L’argomento è stato trattato nel suo discorso al G7 in Puglia, nella sua enciclica Laudato si’, nella recente Laudate Deum e nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace. Il Papa ha sottolineato come “l’AI influenza in modo dirompente l’economia e la società, con possibili impatti negativi sulla qualità della vita, sulle relazioni umane e internazionali, sulla stabilità globale e sull’ambiente“. Un riconoscimento particolare va alla Fondazione per la scelta lungimirante intrapresa.
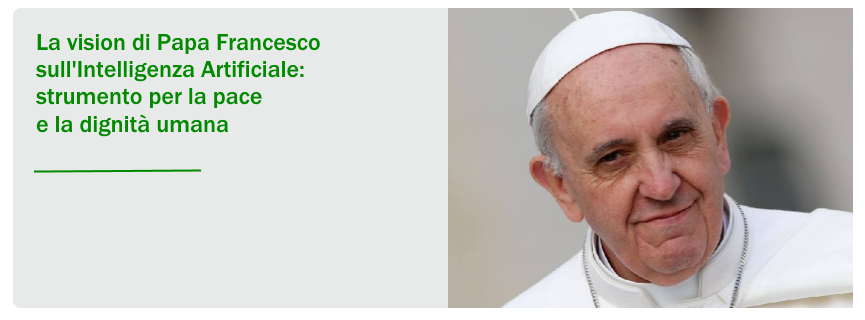
L’adozione del nome Francesco, inedito nella storia papale, è stato il primo segnale di discontinuità. Come ebbe modo di spiegare durante il primo Angelus, la scelta omaggiava “il santo della povertà e della cura del creato”, anticipando temi centrali del suo magistero. Questo gesto simbolico trovò poi concretezza nelle riforme istituzionali, come la semplificazione dei rituali funebri da lui voluta, culminata nella decisione di farsi seppellire a Santa Maria Maggiore anziché nelle Grotte Vaticane.
Papa Francesco è riuscito a trasformare l’immagine del papato attraverso scelte radicali: dall’abbandono degli appartamenti pontifici per residenze più sobrie, alla preferenza per un linguaggio diretto e inclusivo. Un’estetica della povertà che contrastava con certi eccessi clericali criticati nel documento L’abito fa il prete. O forse no, dove si denunciavano presbiteri più attenti alla moda che alla missione. La sua croce pettorale in ferro, invece che in oro, da questo punto di vista è diventata l’icona di questa rivoluzione silenziosa.
Mentre i predecessori si concentravano sulle questioni dottrinali interne, Bergoglio ha portato la Chiesa nelle “periferie esistenziali” del XXI secolo: dai migranti digitali alle vittime del capitalismo algoritmico. Nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2025, ha condannato l’uso delle tecnologie per “promuovere la follia della guerra“, invitando a un’etica della responsabilità che anteponesse l’uomo alle logiche di mercato.
Papa Francesco ha condannato senza appello i “sistemi d’arma autonomi letali”, definendoli una “degenerazione della coscienza umana”. La sua pressione morale ha contribuito all’adozione del Trattato Internazionale sul Controllo dell’AI Militare, ratificato da 89 paesi nel gennaio 2025.
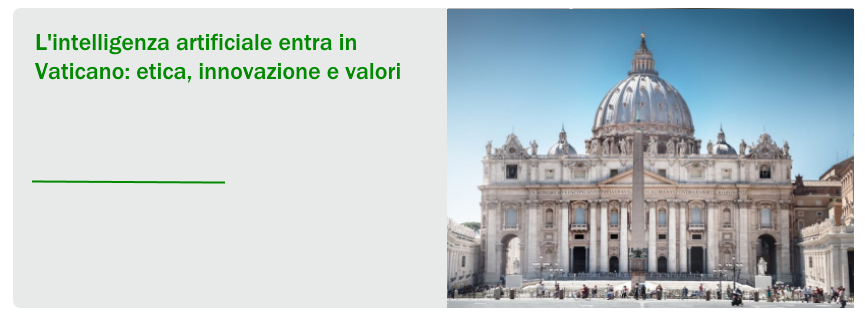
Papa Francesco Bergoglio ha dimostrato che la fede non è nemica del progresso, ma può esserne coscienza critica e faro etico. La sua capacità di coniugare Vangelo e algoritmi, tradizione e innovazione, ha aperto nuove strade per il dialogo tra scienza e spiritualità.
Mentre la Chiesa si prepara a eleggere il suo successore, la sfida sarà preservare questa visione audace senza tradirne lo spirito profetico. Come scritto nell’ultima enciclica: “La tecnologia sia pane condiviso, non pietra dello scandalo”.
In un’epoca di intelligenze artificiali, il suo messaggio rimane una bussola per navigare le complessità del futuro digitale.
