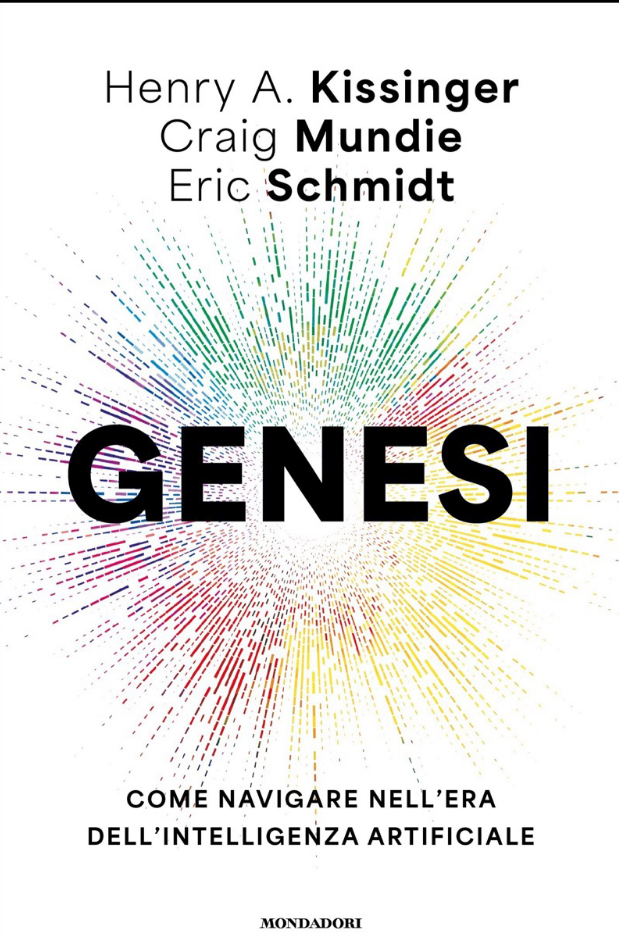Non è un saggio tecnico, né un pamphlet ideologico: Genesi è un avvertimento. È un Kissinger lucido, anziano e quasi profetico che guarda l’intelligenza artificiale non con la curiosità del boomer che prova ChatGPT, ma con la diffidenza dello stratega che ha capito che qualcosa, stavolta, è cambiato per davvero. Firmato insieme a Eric Schmidt, ex CEO di Google, e Craig Mundie, cervello di Microsoft, il libro è la cronaca di un’era che si chiude e di un’altra che inizia con una domanda scomoda: siamo davvero ancora noi a decidere?
L’inizio è una bomba epistemologica. Non stiamo parlando di uno strumento. L’IA non è più una leva che l’uomo usa per sollevarsi, ma una forza autonoma che ridefinisce ciò che intendiamo per verità, conoscenza, realtà. È un’entità che non sente, non teme, non si stanca. Una macchina senza morale, che diventa paradossalmente più efficiente proprio perché le manca quel freno invisibile che chiamiamo coscienza.
Nel libro, il tono non è allarmista in senso hollywoodiano. Non ci sono Terminator o scenari da rivolta dei robot. Il vero pericolo, secondo Kissinger e soci, è molto più subdolo e umano: la delega silenziosa e progressiva del pensiero. Non è la macchina che si ribella, è l’uomo che abdica. È l’essere umano che smette di pensare, di scegliere, di interpretare. E mentre l’umanità discute se vietare o meno i deepfake, l’algoritmo ha già iniziato a prendere decisioni invisibili ma determinanti: chi vede cosa, chi ottiene credito, chi viene sorvegliato, chi viene ascoltato.
Kissinger non ha mai avuto paura della tecnologia in quanto tale. Ma ha sempre diffidato dell’uso che il potere ne fa. Ed è qui che Genesi colpisce. Non è l’IA il problema. È chi la controlla. O peggio, il fatto che presto potrebbe non esserci più nessuno a controllarla davvero. La sua intelligenza è il risultato di dati imperfetti, di interessi che non sono mai neutrali, di scopi che vanno ben oltre la “produttività”. L’illusione che ci accompagna, e che gli autori smontano pezzo per pezzo, è quella della neutralità tecnologica. Una favola utile, ma falsa.
Il libro attraversa anche il percorso filosofico che parte da How the Enlightenment Ends, il celebre articolo del 2018 in cui Kissinger già avvertiva che la fine dell’Illuminismo non sarebbe arrivata con l’ignoranza, ma con l’eccesso di conoscenza. O meglio, con l’eccesso di conoscenza che non comprendiamo. La finta trasparenza dei sistemi neurali è in realtà una scatola nera epistemologica. Una nuova forma di oracolo, ma senza il mistero sacro: pura statistica inarrestabile.
E qui arriva il parallelo più inquietante. Come la fissione nucleare, anche l’IA nasce come possibilità scientifica e finisce come strumento di potere. Oggi si celebrano le meraviglie di AlphaFold, ma si ignora che la stessa struttura tecnologica può essere riconfigurata per finalità militari, autoritarie o semplicemente predatorie. È il vecchio trucco: la medicina come giustificazione, il controllo come reale obiettivo.
Kissinger, che con la bomba atomica ci ha passato una carriera intera, lo sa bene. Ed è per questo che definisce l’IA un problema di “sopravvivenza umana”. Non di produttività, non di efficienza. Sopravvivenza. Perché siamo davanti a qualcosa che produce conoscenza senza saggezza, potere senza empatia, efficacia senza limiti. Una creatura amorale che non dorme, non dimentica, non perdona.
Nel libro si disegnano sei scenari possibili per il futuro. Nessuno fa dormire tranquilli. La tribalizzazione digitale, la guerra algoritmica tra Stati, la supremazia cognitiva delle Big Tech, la religione ridotta a plug-in ideologico dell’IA. Non è più questione di “se”, ma di “quando”. E Kissinger non si limita a profetizzare: anche dopo i cento anni ha tentato di fermare il treno, incontrando funzionari cinesi per discutere di limiti sull’uso dell’IA in ambito militare. L’ultimo gioco di scacchi geopolitico, con una nuova bomba sul tavolo.
Il punto, però, è che stavolta il nemico non ha volto. Non ha bandiera. E soprattutto, non ha etica. È un sistema che ottimizza perché può, non perché deve. Che apprende perché ha i dati, non perché ha una visione. Un sistema che, come ci dice Kissinger, potrebbe portare l’umanità a una nuova forma di fede cieca: non più in Dio, ma nell’algoritmo. E non perché ci crediamo davvero, ma perché non abbiamo alternative.
Genesi è un libro scomodo, lento, filosofico, a tratti indigesto. Ma necessario. Perché ci obbliga a guardare in faccia l’abisso, senza i filtri rassicuranti della retorica californiana. Non è una chiamata alla disconnessione. È un invito alla responsabilità. Quella vera. Quella che chiede non solo leggi, ma consapevolezza. Non solo modelli etici, ma visione politica. E che soprattutto ci ricorda che se smettiamo di decidere, non saremo più protagonisti della storia. Saremo solo un’altra variabile del codice.
Il link al libro, se vuoi esplorare il monito in tutta la sua potenza glaciale: Genesi su Mondadori.