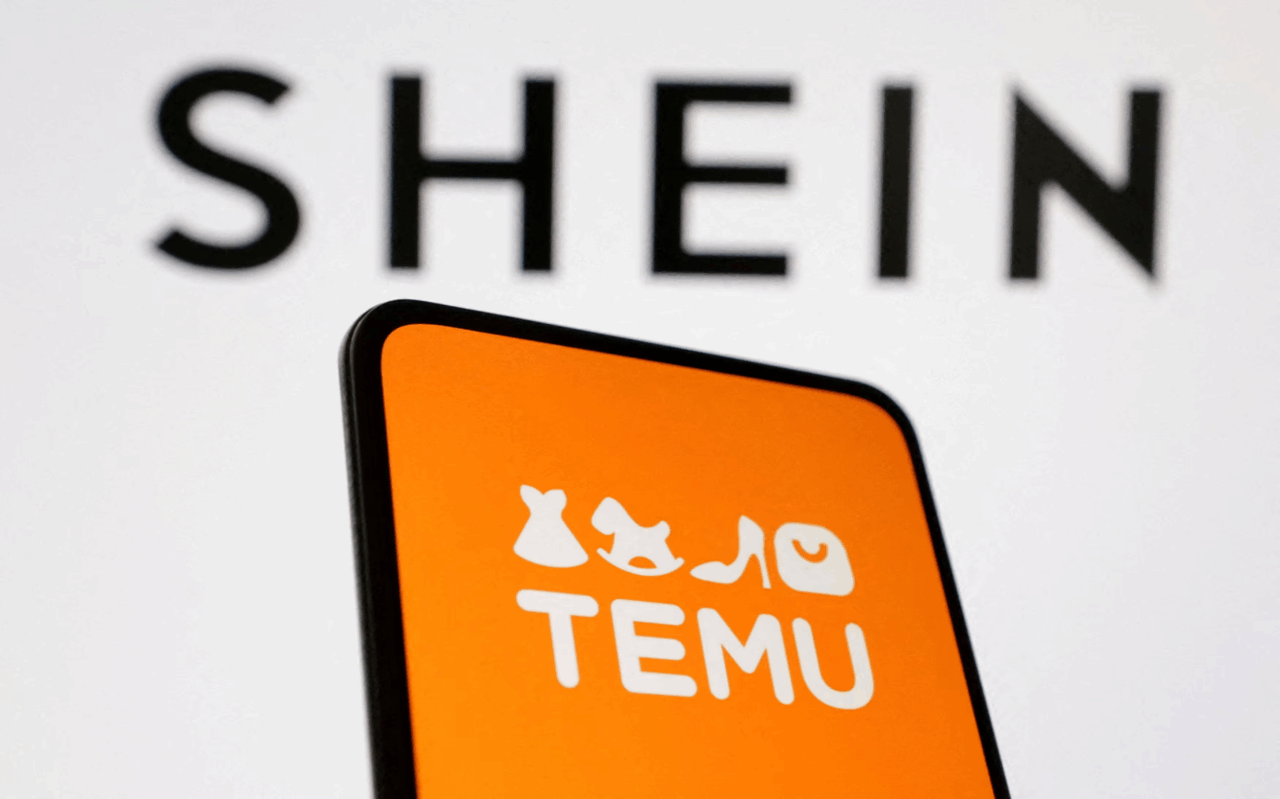La notizia ha il sapore del déjà vu, ma stavolta i numeri sono spietati: dal 25 aprile, i prezzi su Temu e Shein aumentano. Non di qualche spicciolo, ma con una mossa che sa tanto di riposizionamento forzato sul mercato americano, guidato più da Washington che da logiche di business. Il colpo arriva con la delicatezza di un bulldozer: il ritorno del “tariff man” Donald Trump che, ancora in piena campagna elettorale, ha rispolverato il suo armamentario preferito per riequilibrare (a modo suo) la bilancia commerciale con la Cina.
Questa volta l’affondo è chirurgico. Un dazio del 145% sui beni provenienti dalla Cina, fine della cosiddetta “de minimis rule” che consentiva l’ingresso duty-free negli USA per pacchi sotto gli 800 dollari. Una regola che, per anni, ha permesso a Temu e Shein di inondare il mercato statunitense con milioni di pacchi al giorno, facendo leva su logistica iperottimizzata, pricing aggressivo e un uso chirurgico degli influencer per agguantare Gen Z e Millennial.
Le dichiarazioni gemelle diffuse da entrambe le piattaforme non lasciano spazio a dubbi: “a causa delle recenti modifiche alle regole del commercio globale e ai dazi, siamo costretti a ritoccare i nostri prezzi”. Nessun dettaglio sulla portata degli aumenti, ma il tempismo e la simmetria delle dichiarazioni (praticamente identiche) sollevano un sopracciglio anche al più ingenuo degli osservatori. Coordinamento? Pressioni politiche? Un “gentleman’s agreement” tra due colossi per non farsi la guerra in un mercato che sta diventando improvvisamente meno ospitale?
Il modello Temu-Shein si basa su volumi altissimi, margini minuscoli e tempi di consegna quasi magici. Ma questa magia funziona finché la macchina doganale americana resta bendata. Con la fine della “de minimis”, ogni singolo pacco diventa terreno di scontro tariffario, con l’aggravante che Washington non si limita più a parlare: ha cominciato a colpire. E in questo contesto non è un caso che Amazon, l’eterno predatore del commercio elettronico, abbia lanciato un suo hub di prodotti sotto i 20 dollari. Un segnale inequivocabile: il low cost globale non è più solo una questione cinese.
Non è solo una storia di dazi e prezzi. È un cambio di paradigma geopolitico dove il commercio diventa arma strategica. Il made-in-China a basso costo è diventato il simbolo di una globalizzazione che l’America di Trump non vuole più. La narrativa è chiara: sicurezza nazionale, lotta al fentanyl, tutela della proprietà intellettuale. Ma sotto la superficie si cela un’evidente strategia protezionista che strizza l’occhio ai produttori locali e all’elettorato operaio.
Intanto Shein e Temu si muovono. Shein si è “trasferita” a Singapore, cerca di svincolarsi dal legame ombelicale con la Cina. Temu, braccio globale di PDD Holdings, ha tentato un rebranding più “friendly” per l’Occidente. Ma i dati parlano chiaro: il taglio massiccio del budget pubblicitario, rivelato da Sensor Tower, è la cartina tornasole di un business model che scricchiola.
E mentre i pacchi si accumulano nei magazzini, i consumatori americani si affretteranno a fare scorte prima del 25 aprile, ignari che quel paio di leggings o quel robot da cucina a 12 dollari sono gli ultimi esemplari di una specie destinata all’estinzione. La guerra commerciale, a dispetto della retorica, non è mai davvero finita. Ha solo cambiato faccia, passando dalle minacce su Twitter alle linee nei fogli Excel dei dazi doganali.
Il paradosso? Gli influencer che un tempo promuovevano le meraviglie del made in China ora si ritroveranno a sponsorizzare la crisi. E i social media, che vivevano di quelle campagne pubblicitarie, rischiano una dieta forzata. Un effetto collaterale che Meta, Snap, TikTok e soci non avevano messo in conto.