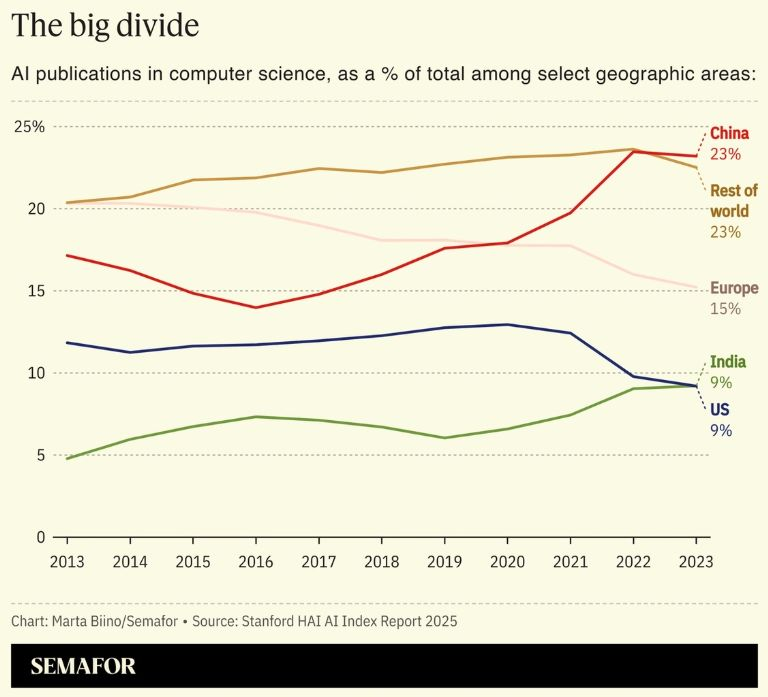Il mondo della tecnologia sta vivendo un’evoluzione profonda e, forse, inevitabile. C’è un movimento crescente che spinge verso la re-distribuzione dei fondi e delle risorse, dove la ricerca di base, quella che ha storicamente permesso alla scienza di progredire, è progressivamente messa da parte a favore di tecnologie più pratiche e già pronte per il mercato. Questo non è semplicemente un cambiamento nei paradigmi di sviluppo, ma un vero e proprio spostamento verso una mentalità più orientata al profitto, con implicazioni che potrebbero essere, se non dannose, almeno molto rischiose per la ricerca stessa.
Lo abbiamo visto con i colossi tecnologici come Google e Meta, i quali, una volta pionieri nella promozione della ricerca accademica, sembrano ora adottare una politica più conservativa e commerciale. Google DeepMind, ad esempio, ha fatto passi indietro rispetto alla tradizione di apertura e condivisione della conoscenza.
Negli ultimi anni, i ricercatori di DeepMind hanno sempre più esitato a pubblicare i loro risultati, per evitare di offrire vantaggi competitivi ai rivali nel settore della IA. La concorrenza è feroce, e, piuttosto che puntare a contribuire al bene pubblico, l’azienda sembra preferire strategicamente la protezione del suo vantaggio tecnologico. Questo movimento non è isolato, e si riflette anche nel modo in cui Meta ha recentemente ridotto la priorità per la ricerca fondamentale nell’ambito dell’intelligenza artificiale, come evidenziato dal declino della sua iniziativa FAIR (Fundamental AI Research). Le risorse, che in passato erano destinate all’esplorazione teorica e a progetti di ricerca di lungo termine, sono ora indirizzate verso la creazione di strumenti generativi di intelligenza artificiale che rispondono alle esigenze immediate del mercato.
Questo cambiamento sta guadagnando terreno anche in Europa, dove iniziative come EuroStack stanno chiedendo un riallocamento dei fondi, passando da progetti di ricerca accademica pura a quelli più orientati a sviluppare tecnologie che siano pronte per il mercato. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la sovranità digitale europea e costruire un’architettura tecnologica europea competitiva, ma anche questo rispecchia un fenomeno simile: l’allontanamento dall’ideale di una ricerca libera e aperta a favore di uno sviluppo tecnologico che sia il più possibile redditizio e funzionale alle necessità di un mercato globalizzato.
C’è chi potrebbe dire che questa direzione, seppur comprensibile dal punto di vista commerciale, rappresenta un grosso passo indietro per l’innovazione scientifica. Quando la tecnologia è sviluppata principalmente per generare profitto, gli interessi pubblici e le implicazioni sociali vengono facilmente sacrificati sull’altare dei margini di profitto. La preoccupazione principale riguarda la priorità che queste aziende danno alle considerazioni economiche piuttosto che etiche. I temi cruciali, come l’equità, la responsabilità e l’impatto sociale delle tecnologie, rischiano di finire in secondo piano, schiacciati dal bisogno di guadagno. E quando la ricerca non è più aperta, quando non ci sono più spazi di condivisione e collaborazione aperta, i progressi scientifici si indeboliscono. Il rischio è che si creino veri e propri silos di conoscenza, custoditi da un numero ristretto di corporazioni che tengono la chiave di ciò che viene sviluppato e, soprattutto, di come ciò viene utilizzato.
Ma c’è anche un altro aspetto da considerare: l’origine dell’innovazione. Le tecnologie più dirompenti e trasformative che conosciamo oggi, come internet, il GPS, e le prime ricerche nell’ambito dell’IA, sono nate grazie ai fondi pubblici e al lavoro accademico. La storia ci insegna che l’innovazione vera e propria, quella che cambia il corso delle cose, non viene solo dal settore privato. La dipendenza esclusiva dalle risorse private per il progresso tecnologico potrebbe risultare limitante, indirizzando la ricerca verso obiettivi che sono al servizio di pochi piuttosto che di tutti. A lungo termine, questa approccio potrebbe non portare ai veri breakthrough che la società potrebbe realmente beneficiare.
Lo scenario che si sta delineando ci invita a riflettere sulle priorità della ricerca tecnologica. Se da un lato è comprensibile che le aziende vogliano proteggere i propri interessi commerciali, dall’altro non possiamo ignorare il rischio che questa concentrazione di potere tecnologico nelle mani di pochi attori stia soffocando il progresso scientifico e l’innovazione collettiva. La tecnologia è, o almeno dovrebbe essere, al servizio dell’umanità nel suo complesso, non solo di coloro che la possiedono. La domanda da porsi è: stiamo davvero investendo nelle tecnologie giuste per un futuro che sia aperto, equo e utile per tutti, o stiamo semplicemente costruendo un altro castello di sabbia, in attesa di essere abbattuti dalla prossima grande onda del mercato?