La corsa globale all’intelligenza artificiale è un tritacarne. Gli Stati Uniti e la Cina sono impegnati in una guerra tecnologica dove il dominio sull’AI non è solo una questione di supremazia economica, ma un braccio di ferro geopolitico. Mentre le startup americane cavalcano la bolla della generative AI a colpi di venture capital e stock option, la Cina gioca la sua partita con ferocia quasi darwiniana: cervelli reclutati, rimpatriati, spremuti. E talvolta, prematuramente sepolti.
Negli ultimi anni, l’industria dell’AI in Cina ha perso alcune delle sue menti più brillanti, stroncate da malattie improvvise, stress, missioni militari o sfortune ad alta quota. Le storie sembrano uscite da un episodio di Black Mirror girato a Pechino: giovani talenti, progetti ambiziosi, pressioni etiche e ambienti di ricerca tossici che non concedono tregua.

Liu Shaoshan, informatico di peso, ha fatto il punto con una dichiarazione tanto precisa quanto cinica: “Il settore si sta sviluppando troppo in fretta. Mentre completi un esperimento, qualcuno ha già pubblicato qualcosa di simile.” Traduzione? In Cina, se lavori nell’AI e dormi otto ore, sei un disertore.
E non si tratta solo di pressione produttiva. C’è anche quella morale. L’AI cambia il tessuto della società: sorveglianza, armi autonome, diagnosi mediche basate su modelli predittivi. Ogni riga di codice può diventare uno strumento di progresso… o controllo.
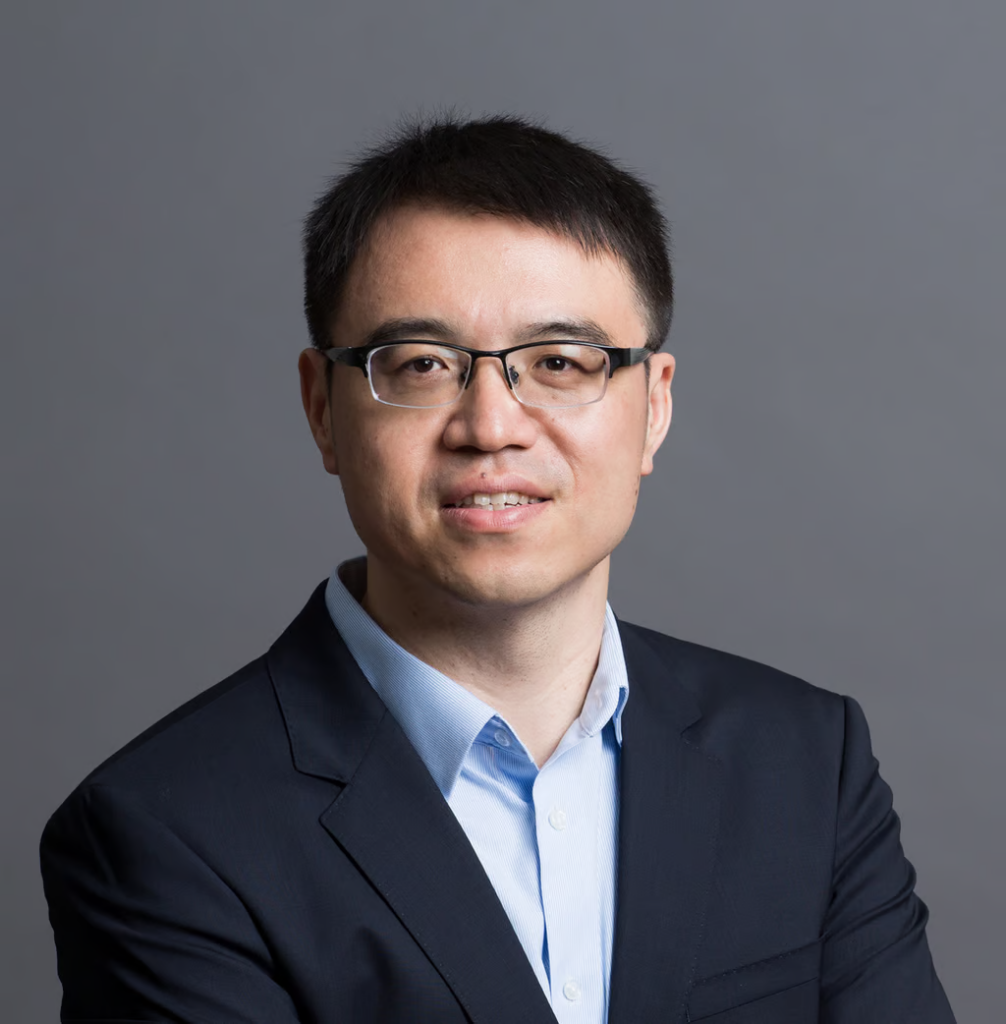
La lista dei caduti nel pieno della carriera è impressionante. Sun Jian, morto a 45 anni nel 2022, era il cervello dietro ShuffleNet e Brain++, colonne portanti di Megvii, una delle stelle del riconoscimento facciale made in China. Ex Microsoft, rientrato in patria con l’illusione di contribuire alla nuova via della seta tecnologica. Invece, ha trovato un ritmo insostenibile e una fine prematura.

Poi c’è Feng Yanghe, morto a 38 anni nel 2023 mentre si recava a una “missione importante”. Missione militare, ovviamente. Lavorava su sistemi AI per simulazioni di guerra – War Skull I e II – per conto dell’Esercito Popolare di Liberazione. Chi ha detto che la guerra non è più un affare da nerd?

Nel 2023 è scomparso anche Tang Xiaoou, fondatore di SenseTime, uno dei “dragoni dell’AI” cinesi. 55 anni, morto dopo una lunga malattia non specificata. Tang era un uomo-ponte tra l’accademia e l’industria, uno dei primi a intuire che il riconoscimento facciale non sarebbe stato solo una funzione da smartphone, ma uno strumento politico ed economico su scala urbana.

Poi il 2024 ha portato via He Zhi, cofondatore di Yidu Tech, a soli 41 anni. Soffocato dall’altitudine del Qinghai, mentre cercava – ironicamente – di digitalizzare il sistema sanitario cinese. Il suo necrologio parla di “pioniere instancabile”. Sarebbe più onesto dire: uno che ha lavorato fino a cadere.

E infine, nel gennaio 2025, è morto Quan Yuhui, 39 anni, tra i principali esperti di elaborazione delle immagini in Cina. Più di 80 pubblicazioni scientifiche, progetti nazionali, riconoscimenti internazionali, incluso l’inserimento tra i top 2% scienziati mondiali secondo Stanford. Tutto questo prima dei 40 anni. Poi, nulla.
Cosa ci raccontano queste morti? Che l’AI cinese non è solo algoritmi e deep learning, ma anche carne, sangue, insonnia e un sistema che divora chi lo alimenta. L’ideale confuciano dell’eccellenza a tutti i costi si sposa con la brutalità della competizione globale. Si torna in patria per “contribuire”, ma si finisce stritolati da un sistema che non prevede pausa, né fallimento, né salute mentale.
È facile applaudire DeepSeek e le sue sfide a OpenAI, o esaltare i modelli linguistici locali come segno della rinascita tecnologica cinese. Ma dietro ogni token predetto si nasconde un ricercatore che ha probabilmente rinunciato alla famiglia, al sonno, e in alcuni casi, alla vita stessa. Forse l’AI sarà davvero il prossimo oracolo della civiltà. Ma per molti, è già diventata una moderna macchina del sacrificio.
