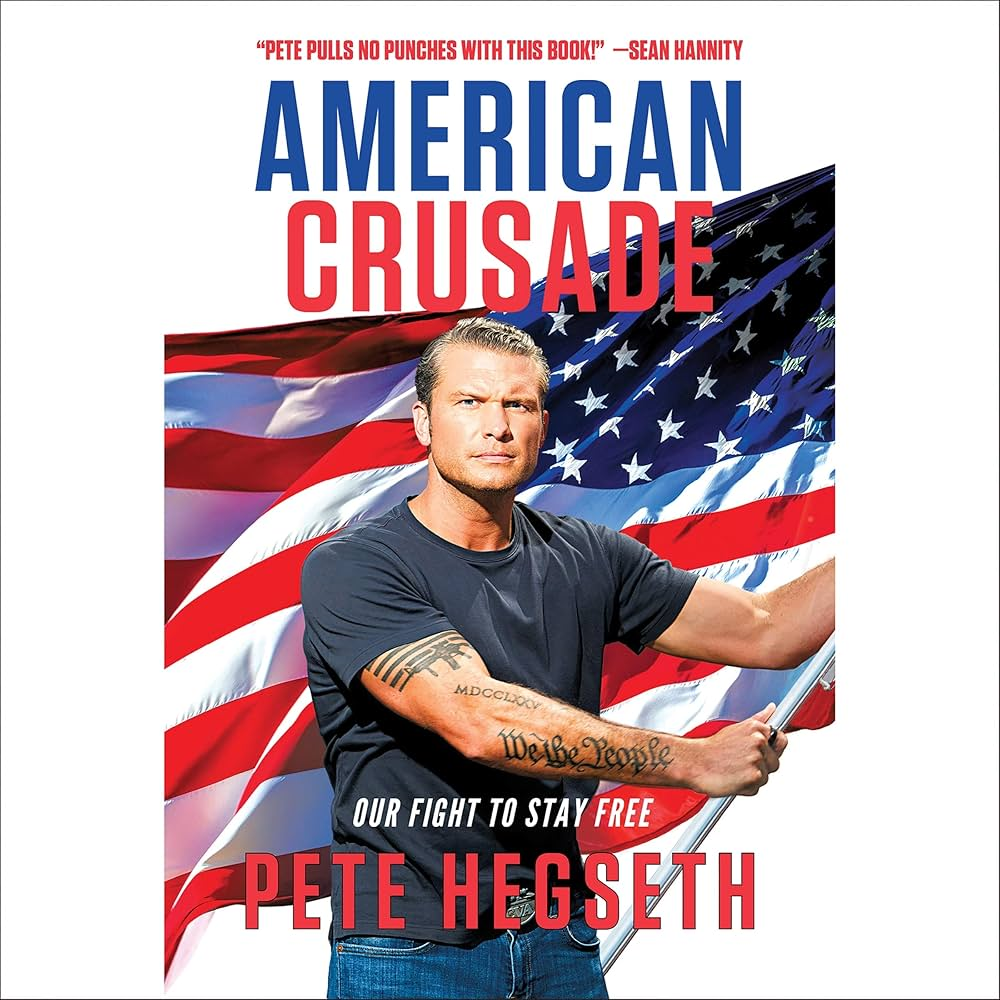Benvenuti nel nuovo episodio della soap opera Tariff Wars: Made in America, dove ogni giorno è una roulette russa per le supply chain globali. Howard Lutnick, Segretario al Commercio USA e fedele araldo del trumpismo 2.0, ha rivelato in un’intervista alla ABC che l’amministrazione ha deciso di separare i destini tariffari dei prodotti tech – smartphone, computer, semiconduttori e altra elettronica di prima fascia – da quelli soggetti ai dazi “reciproci” annunciati ad aprile. Ora, questi prodotti rientreranno sotto una nuova categoria: le “tariffe settoriali”.
Una mossa che sa più di guerra ideologica che di strategia industriale, e che porta con sé il solito retrogusto amarognolo di nazionalismo economico condito da paranoia geopolitica. Il riferimento di Lutnick ai dazi del 25% imposti sulle auto è chiaramente un avvertimento su dove si stia andando a parare: più che una politica commerciale, sembra un’evangelizzazione del reshoring forzato.
La linea è chiara: portare a casa la produzione di tutto ciò che fa girare la macchina digitale americana, dai chip ai pannelli piatti, come se bastasse un decreto per trasformare l’Ohio in una nuova Taipei. Lutnick, tra una smorfia e l’altra, ha buttato lì che i dettagli di queste nuove tariffe appariranno sul Federal Register nel giro di pochi giorni, e diventeranno effettive “tra circa un mese”.
La motivazione? L’ennesima litania: “non possiamo dipendere dal Sud-est asiatico per tutto ciò che ci fa funzionare”. Una frase che suona come uno slogan da talk-show post-apocalittico, ma che traduce un cambiamento profondo nell’approccio USA: se Biden era protezionista con i guanti bianchi (vedi i 100% di dazio sui veicoli elettrici cinesi), Trump è il buttafuori ubriaco del WTO, pronto a sbattere fuori chiunque non parli “americano fluente”.
Ma dietro la facciata muscolare, c’è un retroscena molto meno epico: la volatilità dei mercati. Il 2 aprile Trump ha scatenato l’inferno tariffario – le celebri “tariffe del Giorno della Liberazione” – salvo fare marcia indietro 24 ore dopo, quando Wall Street ha preso una botta, i rendimenti del Tesoro sono schizzati e il dollaro ha cominciato a perdere smalto. La sola eccezione? La Cina, che resta il bersaglio numero uno, nonostante l’impasse diplomatico e le continue uscite offensive del vicepresidente J.D. Vance, che ha definito i cinesi “contadini”, per poi giustificarsi con la solita retorica da guerra fredda 2.0.
Lutnick, incalzato sulla gaffe razzista del VP, ha evitato l’argomento con la grazia di un pugile suonato, ma non ha resistito a rilanciare sul tema: “La Cina ci ha attaccati economicamente. Hanno distrutto le nostre aziende con l’aiuto del loro governo. Ci hanno rubato la manifattura.” Un disco rotto, ma ormai è chiaro che questa narrativa è la benzina della nuova dottrina economica americana.
Questa escalation protezionistica, mascherata da patriottismo industriale, ha implicazioni molto più profonde per l’Asia – in particolare per le grandi piattaforme tech come Meta, che stanno riposizionandosi in funzione dei nuovi venti di Washington. La migrazione delle catene di fornitura, la riconfigurazione dei flussi commerciali e il ruolo sempre più fragile dei Paesi del Sud-est asiatico come hub della manifattura globale saranno i veri campi di battaglia del prossimo decennio digitale.
Nel frattempo, il messaggio è chiaro: chi fa elettronica dovrà ballare al ritmo di Mar-a-Lago, o prepararsi a pagare dazi come penitenza. Perché, in fondo, l’America di Trump non vuole solo prodotti made in USA, vuole che anche la globalizzazione parli con accento del Midwest.