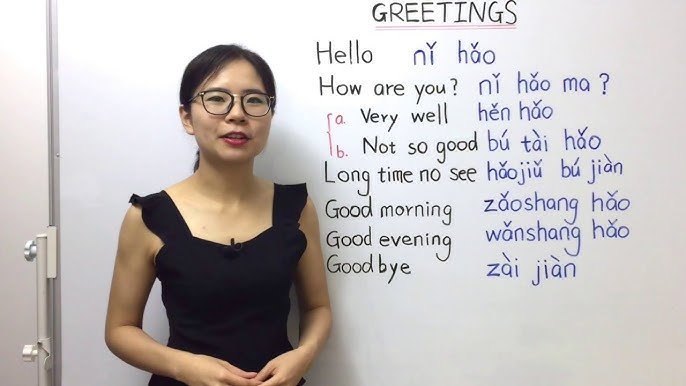Il sipario si è alzato sul secondo atto della guerra commerciale USA-Cina e stavolta non si tratta solo di dazi. È un confronto strategico, una partita a scacchi geopolitica, con Washington e Pechino incastrati in una dinamica di escalation reciproca che trascende il semplice commercio. Trump, tornato alla Casa Bianca con la sottile eleganza di un bulldozer in cristalleria, ha innalzato i dazi al +125% (quindi in totale dovrebbero essere 145%) contro la Cina. Una mossa che sa più di vendetta che di strategia economica, mentre a tutti gli altri partner commerciali ha concesso una graziosa tregua di 90 giorni. Per Pechino, invece, nessun salvacondotto.
Non siamo più nel 2018. Oggi, con le supply chain globali già fratturate e l’economia mondiale in modalità “survival”, la mossa di Trump appare come un tentativo di rianimare il suo brand politico attraverso il nazionalismo economico più tossico (Monroe). Ma la Cina non è quella che era. Non c’è più l’ombra di un compromesso tattico: Pechino ha messo in chiaro che è pronta a pagare qualsiasi prezzo pur di non piegarsi. Lo ha detto Zhao Minghao, esperto del Centre for American Studies di Shanghai, e lo ha ribadito ogni funzionario cinese coinvolto: questa è una guerra di risolutezza, non di numeri.
Il paradosso è che Trump, l’uomo che si vanta di essere il più grande negoziatore vivente, si trova oggi in un vicolo cieco diplomatico. Non può arretrare senza perdere faccia, né può avanzare senza affondare interi settori della sua stessa economia. La Cina, dal canto suo, gioca di fioretto, come sempre e come ha fatto con Deepseek: niente telefonate, nessun gesto di sottomissione, solo segnali diplomatici calcolati al millimetro. Trump ha mal interpretato l’approccio cinese. Pensava che bastasse aumentare la pressione perché Xi Jinping lo chiamasse supplichevole. Ma Pechino non gioca a quel gioco, non ci ha mai giocato e non è stato mai attore di nessun reality.

Nel frattempo, dietro le quinte, i funzionari mantengono i canali aperti, come dimostrano i colloqui tra il vicepremier He Lifeng e il rappresentante commerciale Jamieson Greer. Tuttavia, sono scambi cordiali da teatro, più per evitare il collasso che per risolvere davvero qualcosa. In superficie, entrambi i leader si fanno forti, ma il rischio è che il tempo giochi contro tutti: le economie rallentano, gli investitori si allarmano, i mercati asiatici si irrigidiscono.
Xi Jinping ha già dato il via a un piano di diversificazione. La quota delle esportazioni cinesi verso gli USA è crollata al 13,4% nel 2024, contro il 21,6% del 2017. Il messaggio è chiaro: il Dragone non è più appeso all’uncino americano. Ha già stretto nuovi legami con l’Asean (Association of South East Asian Nations) e ora punta a rinsaldare le catene del valore con i vicini regionali. Trump può alzare i dazi quanto vuole, ma se il prodotto non entra più nel mercato americano, la Cina lo spedirà altrove, magari a sconto, giusto per fare un dispetto.
Ma attenzione al teatro di facciata, le guerre commerciali si vincono anche salvando la faccia all’avversario. Nixon nel ‘72 voleva aprire alla Cina ma finse che fosse stato invitato. Un balletto diplomatico dove nessuno perde, ma tutti possono dire di aver vinto. Ecco, forse è proprio lì che ci si dirige: verso un punto d’incontro camuffato da vittoria reciproca.
La Cina potrebbe fare qualche gesto simbolico, come un impegno ad acquistare più LNG (gas naturale liquefatto), o riaprire consultazioni sugli investimenti stranieri. Nulla che tocchi i nervi scoperti di Pechino, ma abbastanza per permettere a Trump di dire “ho vinto io”. E lui, che vive di narrativa, potrebbe cogliere l’assist. Non perché ci creda davvero, ma perché serve alla sua rielezione. La diplomazia, dopotutto, è l’arte di far sembrare inevitabile ciò che è stato disperatamente negoziato in segreto.
L’ultimo atto? Il passaggio dai dazi alle sanzioni tecnologiche. Perché Trump sa che la guerra doganale è a un punto morto, e allora si prepara al secondo fronte. Con l’aria di chi non gioca per la pace, ma per la resa incondizionata dell’avversario.
Ed è qui che la Cina, pur mantenendo la maschera di compostezza confuciana, lancia un messaggio all’Occidente: noi resistiamo, anche da soli. E, implicitamente, agli altri paesi: se volete ancora un sistema commerciale multilaterale, qualcuno dovrà pur avere il coraggio di dire “no” agli Stati Uniti.
E oggi, quel qualcuno, parla mandarino.