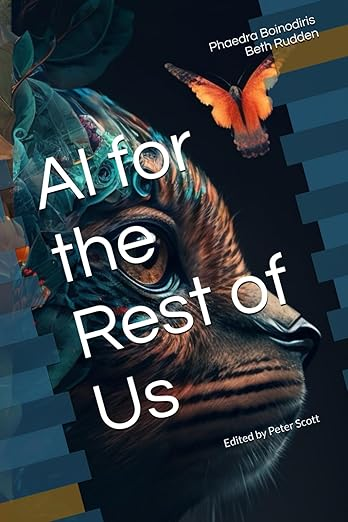Anche il più “umanista” dei libri sull’intelligenza artificiale è già un prodotto del sistema che pretende di criticare. Ma se a suggerirtelo è qualcuna che sa leggere tra le righe, allora forse vale la pena fidarsi.
Non capita spesso che un libro tecnico riesca a promettere rivoluzioni morali con il tono di un TED Talk motivazionale, ma “AI for the Rest of Us” di Phaedra Boinodiris e Beth Rudden, curato da Peter Scott, ci prova con convinzione. Un titolo apparentemente inclusivo, quasi ingenuo, che cerca di restituire il controllo dell’intelligenza artificiale alle masse, o almeno di far credere che sia possibile. È un’opera a metà tra il manifesto etico e la guida concettuale, scritta per chi vuole sentirsi parte del cambiamento senza dover imparare a programmare in Python.

L’approccio del libro è chiaro fin da subito: i dati sono artefatti dell’esperienza umana. La frase suona bene, quasi poetica, ma traduce una verità fondamentale che l’industria dell’AI preferisce ignorare: ogni dataset è un prodotto di scelte, omissioni e bias. Gli autori ribadiscono con forza che se vogliamo costruire un’AI equa e rappresentativa, dobbiamo includere la più ampia diversità possibile di esseri umani nel processo di creazione dei modelli. Giusto. Nobile. Utopico.

Nel corso delle sue 200 e passa pagine, il libro non entra mai davvero nel dettaglio tecnico. Non è un testo per chi lavora in AI, ma per chi vuole capirla senza rimanerne vittima. Propone un “modello concettuale” di dati, distingue bene cosa sanno fare gli umani e cosa fanno meglio le macchine, e introduce con tono quasi da catechismo la nuova etica dell’algoritmo: accountability, fairness, explainability, robustness, kindness. Sì, hai letto bene: kindness. La gentilezza come principio cardine dell’AI, in un mondo dove i modelli vengono addestrati su miliardi di dati spesso raccolti senza consenso. C’è del tenero, quasi infantile, in questa visione della tecnologia come figlio da educare con amore.
Ma è proprio qui che il libro mostra i suoi limiti. Perché se da un lato denuncia le storture della governance dell’AI, dall’altro sembra credere davvero che l’inclusione e la consapevolezza possano da sole correggere un ecosistema che si fonda su profitti, sorveglianza e controllo. È un’idea bella, sì. Ma come direbbe un CTO con qualche cicatrice sulla schiena: il problema non è il codice, è chi lo paga.
Il libro però ha un pregio non da poco: introduce ai lettori generalisti la necessità di pensare l’AI come un fatto socio-tecnico. La fiducia non si conquista con la trasparenza del modello, ma con la trasparenza del potere. Gli autori lo sanno e lo scrivono. Peccato però che evitino di nominare davvero i colpevoli: le big tech, i modelli chiusi, i governi complici. Parlano di “cultura” e “advocacy” quando servirebbero regolamentazioni e sanzioni.
Alla fine, AI for the Rest of Us è un buon punto di partenza per chi si avvicina ora a questi temi e vuole qualcosa di umano, empatico, quasi terapeutico. Ma per chi ha già visto cosa può fare un algoritmo nel mondo reale dai sistemi predittivi della giustizia penale all’allocazione di risorse sanitarie il testo lascia un retrogusto dolceamaro. È come un corso di educazione civica tenuto in una stanza dove il consiglio d’amministrazione sta già approvando la prossima killer app basata sull’AI.
Resta una lettura utile, soprattutto per chi crede ancora che valga la pena provare a “essere buoni genitori dell’AI”. Anche se là fuori, mentre cerchi di essere un bravo papà dell’algoritmo, qualcun altro sta già addestrando il suo modello per venderlo al miglior offerente.
Grazie Marina dell’ottimo consiglio.